 |
||
|
||
 |
 |
||
|
||
 |
|
![]()
TRADIZIONE DI BORDIGHERA
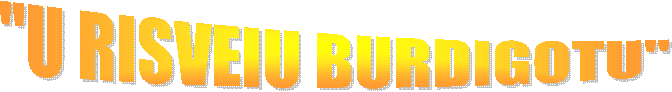
Bordighera è la città europea a latitudine più settentrionale dove nascono spontanee le palme da datteri, in particolare la qualità “Phoenix dactylifera” che è quella più rustica, che molti turisti avranno ritrovato nelle oasi tunisine (Toseur, Gabes) o marocchine (Tinehir, Erfoud). Possiamo quindi affermare, con grande serenità, che Bordighera è la città delle palme per eccellenza.
Ed è appunto nella città delle palme che si svolge, con particolare suggestione, la ricorrenza religiosa della “Domenica delle Palme”. Nei giorni precedenti la festa, nei vari magazzini del Paese Alto, ferve il lavorio delle donne che con tramandata abilità intrecciano i “semelli”, i quali rappresentano il prodotto più significativo delle palme bordigotte (i datteri quasi mai raggiungono una soddisfacente maturazione). Per ottenerli – i semelli – occorre per tempo legare il cuore della palma affinché, con opportuna azione clorofilliana, raggiungono il colore desiderato: più bianco per la nostra Pasqua; più verde per quella ebraica che cade in autunno.
Quello della legatura delle palme è un lavoro ardito, praticato da esperti “Parmurà” i quali si arrampicano fino in cima alla pianta e, debitamente legati, operano attorno al ciuffo secondo un metodo che si tramanda da generazioni.
Quello che i bordigotti portano in piazza per la benedizione si chiama “parmurelu” ed è il risultato di una filiera produttiva che affonda le sue radici addirittura nei secoli.
Intanto le palme. A Bordighera amiamo credere che le abbia portate dalla Tebaide il nostro Santo patrono, sant’Ampelio. Ma è più probabile che siano stati i Fenici, durante le loro ricorrenti scorribande, a scaricare sul nostro territorio i noccioli dei datteri con i quali si nutrivano nelle traversate mediterranee. Qui i semi trovarono un microclima ideale per prosperare e riprodursi. La conca di Artiglia, ad esempio, la costa del Beodo a ridosso del cimitero e villa Garnier, sono le località dove ancora oggi prosperano (ormai residue) famiglie di palme. In altri angoli della città inoltre, si possono trovare gruppi isolati di Phoenix e anche di altre qualità.
La tradizione dei “Parmureli” invece è fatta risalire ad un episodio (non si sa quanto leggendario) che avrebbe conferito a Bordighera il privilegio di fornire ogni anno le palme pasquali al Papa.
Correva l’anno 1586 allorchè papa Sisto V decise di far erigere, in Piazza San Pietro, l’obelisco egiziano dedicato da Caligola ad Augusto e Tiberio. Nel silenzio generale della difficile operazione di sollevamento, un grido lacerò la piazza: “Aiga ae corde” impartì il capitano di ventura Bresca che assisteva alla manovra. Il perentorio suggerimento venne ascoltato e le corde, adeguatamente bagnate, si contrassero permettendo così il definitivo assestamento dell’obelisco che era pericolosamente in bilico. Il Papa, riconoscendo il tempismo e l’utilità di quel grido, non solo non condannò il Bresca, ma gli conferì il privilegio di fornire ogni anno al Vaticano le palme pasquali.
Da allora varie famiglie di Bordighera hanno onorato l’antico privilegio, in particolare la famiglia Allavena e la famiglia Palmero il cui decano “parmurà” , Ampelio nel 1990 è morto (72.enne) cadendo da una palma che stava legando. Attualmente non si conoscono più parmurà tradizionali, anche in considerazione della tecnologia sopravvenuta. L’ultimo nome che mi piace ricordare è quello di Luciano Traverso che mi auguro riesca a tramandare ancora quello che lui ha assunto dai vecchi “parmurà”.
Quando, la domenica delle Palme, il parroco si presenta sul sagrato imbracciando il “parmurelu” più bello e più artisticamente lavorato (che gli viene offerto ogni anno dalle famiglie), tutti i presenti alzano al cielo il loro, per consacrarlo con la solenne benedizione. Il “parmurelu” benedetto viene tradizionalmente appeso in casa per la protezione di tutta la famiglia. La tradizione impone che ogni anno i vecchi “parmureli” (oramai rinsecchiti) vengano bruciati poiché, essendo benedetti, non devono assolutamente conoscere l’onta della raccolta rifiuti, neanche se differenziata!
Giancarlo Pignatta
Marchio doc ai parmureli per Papa Benedetto XVI
I "PARMURELI" diventeranno doc.
Non solo: l'arte di intrecciare le foglie di
palma sarà insegnata attraverso un corso di formazione, affinché questa
tradizione antichissima venga mantenuta e possa offrire nuovi sbocchi
occupazionali. Sono le principali novità emerse ieri mattina nel corso della
conferenza stampa sulla presenza delle composizioni in
 Vaticano,
in occasione della Domenica delle Palme. Un'altra novità è che i parmureli,
domenica, saranno ancor più protagonisti rispetto agli anni passati: oltre ad
essere benedetti prima della celebrazione della Santa Messa dellà Domenica delle
Palme, saranno donati alle oltre duemila persone presenti sul sagrato di San
Pietro, oltre che - come tradizione - ai Cardinali e ai Vescovi, in tutto un
centinaio. Le dimensioni delle composizioni, logicamente, saranno differenti
(quelle per vescovi e cardinali misureranno un metro) e ancora più grande sarà
quella destinata al Santo Padre, che supererà i due metri e mezzo. I parmureli
verranno donati al Papa e al Vaticano grazie all'impegno del Centrò Studi e
Ricerche per le Palme e alla Cooperativa Sociale Il Cammino, con il patrocinio e
l'ufficialità della Fondazione per i Beni e le Attività Artistiche della Chiesa
e alla compartecipazione dei Comuni di Bordighera e Sanremo, ieri rappresentanti
rispettivamente dal Sindaco Giovanni Bosio e dall'assessore all'agricoltura
Giovanni Allavena, e dal Presidente del consiglio comunale Bruno Marra e dal
consigliere delegato alla floricoltura Alberto Biancheri.
Vaticano,
in occasione della Domenica delle Palme. Un'altra novità è che i parmureli,
domenica, saranno ancor più protagonisti rispetto agli anni passati: oltre ad
essere benedetti prima della celebrazione della Santa Messa dellà Domenica delle
Palme, saranno donati alle oltre duemila persone presenti sul sagrato di San
Pietro, oltre che - come tradizione - ai Cardinali e ai Vescovi, in tutto un
centinaio. Le dimensioni delle composizioni, logicamente, saranno differenti
(quelle per vescovi e cardinali misureranno un metro) e ancora più grande sarà
quella destinata al Santo Padre, che supererà i due metri e mezzo. I parmureli
verranno donati al Papa e al Vaticano grazie all'impegno del Centrò Studi e
Ricerche per le Palme e alla Cooperativa Sociale Il Cammino, con il patrocinio e
l'ufficialità della Fondazione per i Beni e le Attività Artistiche della Chiesa
e alla compartecipazione dei Comuni di Bordighera e Sanremo, ieri rappresentanti
rispettivamente dal Sindaco Giovanni Bosio e dall'assessore all'agricoltura
Giovanni Allavena, e dal Presidente del consiglio comunale Bruno Marra e dal
consigliere delegato alla floricoltura Alberto Biancheri.
La presenza dei parmureli della Riviera in
Vaticano è recente. Fino a qualche anno fa il Comune di Bordighera inviava a
Roma solo le foglie di palma, custodite nella juta. Il compito di intrecciarle
era svolto dalle suore amaldolesi. «Le suore - spiega Giovanni Allavena,
assessore di Bordighera, la cui famiglia si dedica da sempre all'arte di
intrecciare le foglie di palma - hanno terminato questa attività da tempo, e
c'era il rischio di dover interrompere questa tradizione. Per questo motivo,
invece che l'invio delle foglie di palma, da Bordighera si è cominciato a
mandare le composizioni già pronte». E' stato un successo, e oggi i
parmureli sono appunto tra i protagonisti della Domenica delle Palme.

La Storica foto di Giovanni Paolo Il con in mano i parmureli della Riviera
Domenica prossima le palme
intrecciate.jpg)
sul sagrato di San Pietro
«Uno dei momenti più indimenticabili - prosegue il sindaco di Bordighera Giovanni Bosio - rimane la figura del Papa Giovanni Paolo II, nel 2004, una delle sue ultime apparizioni, con in mano un parmurelo. E ancora in mano all'attuale Santo Padre, pochi giorni prima della sua nomina a successore di Karol Wojtyla».
La crescita dell'impegno per assicurare la presenza in Vaticano delle foglie di palma intrecciate, quindi, ha spinto a pensare al marchio doc. Un aspetto che è stato illustrato da Claudio Littardi, responsabile del settore Beni ambientali del Comune di Sanremo e presidente del Centro studi e ricerche sulle palme. «Le palme sono un patrimonio e un simbolo del nostro territorio. A loro è legata anche l'immagine turistica della Riviera. Per questo motivo, si è pensato .di certificare i parmureli, in modo che vengano tutelati e siano, immediatamente riconoscibili come provenienti dalla nostra zona. Allo stesso tempo, si vuole creare una scuola di formazione, dove venga insegnato, oltre a come preparare le composizioni, anche il metodo di potatura delle palme e tutto quello che riguarda questa pianta. Il marchio doc dovrà certificare sia il parmurelo che la palma dalla quale è ricavata la foglia». Che, va sottolineato, appartiene alla palma dattilifera e non alla canariensis. La certificazione servirà anche a impedire eventuali "imitazioni".
 Le palme della Riviera dei Fiori
divennero
Le palme della Riviera dei Fiori
divennero
 protagoniste della Domenica delle Palme grazie
allo slancio sincero del Capitano Giovanni Bresca,
presente in Vaticano il giorno in cui vi venne eretto
l’obelisco più famoso di Roma Antica, e che consentì di
evitare una strage di fedeli, accorsi per l’occasione. I
fatti si riferiscono al 1586, anno in cui, per volere di
Papa Sisto V, l'architetto Domenico Fontana collocò in
Piazza San Pietro il gigantesco obelisco egizio
trasportato a Roma da Caligola nel 39 d.C. Operazione
ardita: l'obelisco, che ancor oggi fa bella mostra di sé
nel centro della suggestiva piazza, è alto 26 metri e
pesa 350 tonnellate. Per l’operazione vennero impiegati,
pare, novecento operai, centoquaranta cavalli e
quarantaquattro argani. Il 10 settembre, al momento di
issare definitivamente l’obelisco, così come da espressa
disposizione del Santo Padre, chiunque avesse osato
proferir verbo durante la delicata e rischiosa
operazione sarebbe stato condannato alla pena di morte.
A un certo punto, però, l’obelisco vacillò
pericolosamente – le funi con cui si stava sollevando
l’enorme scultura monolitica erano prossime al punto di
rottura – e Giovanni Bresca,
incurante della pena di morte certa che l’avrebbe
colpito gridò: 'Aiga ae corde!' (Acqua alle corde).
L’imperioso consiglio del marinaio ligure venne subito
accolto dagli ingegneri del
Vaticano, e si evitò così il surriscaldamento delle
gomene che sostenevano l’obelisco, consentendo di
portare a buon fine l’impresa. Il Papa non punì l’audace
capitano Bresca, anzi volle compensarlo accordando a lui
e alla sua discendenza il privilegio di poter inviare a
Roma i “parmureli” necessari per le feste pasquali in
San Pietro. Da allora, da oltre quattro secoli, le città
di Sanremo e Bordighera hanno legato il loro nome alla
tradizionale cerimonia della benedizione delle palme,
per la domenica che precede la Santa Pasqua.
L’importanza e la considerazione che il Vaticano
riservava a questo privilegio assunse anche connotati
curiosi. Quando le fronde di palma giungevano a Roma via
mare, l’imbarcazione che le trasportava, giunta alla
foce del Tevere, innalzava un “parmorelo” sul suo albero
maestro. Questa “bandiera” dava alla barca ligure il
diritto di precedenza su tutte le altre imbarcazioni,
consentendo alle foglie di palma rivierasche di
raggiungere il più celermente possibile il Vaticano.
protagoniste della Domenica delle Palme grazie
allo slancio sincero del Capitano Giovanni Bresca,
presente in Vaticano il giorno in cui vi venne eretto
l’obelisco più famoso di Roma Antica, e che consentì di
evitare una strage di fedeli, accorsi per l’occasione. I
fatti si riferiscono al 1586, anno in cui, per volere di
Papa Sisto V, l'architetto Domenico Fontana collocò in
Piazza San Pietro il gigantesco obelisco egizio
trasportato a Roma da Caligola nel 39 d.C. Operazione
ardita: l'obelisco, che ancor oggi fa bella mostra di sé
nel centro della suggestiva piazza, è alto 26 metri e
pesa 350 tonnellate. Per l’operazione vennero impiegati,
pare, novecento operai, centoquaranta cavalli e
quarantaquattro argani. Il 10 settembre, al momento di
issare definitivamente l’obelisco, così come da espressa
disposizione del Santo Padre, chiunque avesse osato
proferir verbo durante la delicata e rischiosa
operazione sarebbe stato condannato alla pena di morte.
A un certo punto, però, l’obelisco vacillò
pericolosamente – le funi con cui si stava sollevando
l’enorme scultura monolitica erano prossime al punto di
rottura – e Giovanni Bresca,
incurante della pena di morte certa che l’avrebbe
colpito gridò: 'Aiga ae corde!' (Acqua alle corde).
L’imperioso consiglio del marinaio ligure venne subito
accolto dagli ingegneri del
Vaticano, e si evitò così il surriscaldamento delle
gomene che sostenevano l’obelisco, consentendo di
portare a buon fine l’impresa. Il Papa non punì l’audace
capitano Bresca, anzi volle compensarlo accordando a lui
e alla sua discendenza il privilegio di poter inviare a
Roma i “parmureli” necessari per le feste pasquali in
San Pietro. Da allora, da oltre quattro secoli, le città
di Sanremo e Bordighera hanno legato il loro nome alla
tradizionale cerimonia della benedizione delle palme,
per la domenica che precede la Santa Pasqua.
L’importanza e la considerazione che il Vaticano
riservava a questo privilegio assunse anche connotati
curiosi. Quando le fronde di palma giungevano a Roma via
mare, l’imbarcazione che le trasportava, giunta alla
foce del Tevere, innalzava un “parmorelo” sul suo albero
maestro. Questa “bandiera” dava alla barca ligure il
diritto di precedenza su tutte le altre imbarcazioni,
consentendo alle foglie di palma rivierasche di
raggiungere il più celermente possibile il Vaticano.
dal "Secolo XIX "
PAOLO ISAIA